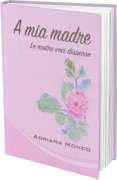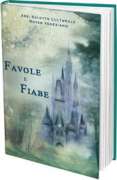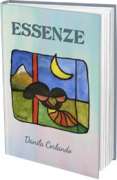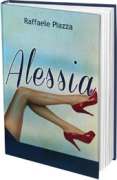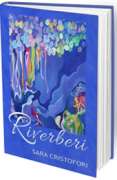Non fornisco schemi. Cercherò di far rientrare i nomi degli oggetti incontrati via via in un racconto che li spogli della didascalità o del nozionismo. Di modo che il tutto assuma quel carattere di romanzo che, fin dal titolo, ho voluto assegnargli.
1) Il Romanico.
Ciò che chiamiamo Romanico si può a malapena definire uno stile, abbracciando un arco di tempo vastissimo, il che già da sé comporta una incontrovertibile evoluzione tecnica, storica e culturale. Tuttavia, ravvisiamo la legittimità di questa intestazione sin nell’indizio incorporato nel nome stesso, che ce ne rivela il lignaggio: Roma, i Romani: un’arte, uno stile, un modus vivendi derivanti in linea retta dall’Impero tramontato degli avi. Potremmo azzardarci ad immaginare che il primo Romanico non sia altro che l’arte romana divenuta cristiana (nel Paleocristiano, per l’esattezza).
Ma in sé il Romanico evoca anche muri spessi, chiese come fortezze, ambienti molto scuri e raccolti, espressioni più di una religione che di un’arte, o una decorazione. In realtà, qui parliamo di templi, non di arte. La figurazione scultorea o dipinta, vi svolgeva un ruolo funzionale e il fulcro a cui tale funzionalità ambiva era quello della devozione. È questa la radice che dobbiamo esumare e sviscerare se vogliamo carpirne la genesi. Perché, se anche il tempio è in sé architettura, e questa pone ragioni di ordine strutturale, vi è una struttura più prima e categorica che la precede, ed è quella del senso, del contenuto: prima bisogna aver qualcosa da dire, poi si mette in cantiere la struttura che lo espliciterà. È per afferrare, rivelare e divulgare la verità che emerge la necessità di erigere un tempio. Il tempio è sempre innalzato, o alle gesta degli uomini, ovvero alla grandezza degli dèi: si tratta sempre e comunque del racconto di ciò che agli occhi chi edifica appare vero, nobile e bello, in una parola: trascendentale, qualcosa che scavalca la discontinuità dell’essere e approda all’immortalità.
L’esempio più coerente di tale “immortalazione” era ancora, all’alba del Medioevo, lo splendente modello imperiale dei Fori, la fama quasi leggendaria di Roma. Il grandioso richiamo dei suoi giganteschi monumenti marmorei esercitava tuttora il fascino esemplare di ciò che è eterno, incrollabile, immortale. Ma se al di sopra di Roma si installava ora l’autorità del Dio dei Cristiani, si rendeva necessario allogare questa divinità in un luogo degno di tale accoglienza, in una “casa” che, al pari del grandioso lascito monumentale dell’Impero, fosse in grado di resistere alle offese del tempo, che fosse cioè eterna. Molti templi romani divennero chiese; molte chiese vennero edificate saccheggiando per secoli i templi romani. Ma non bastava.
In un tempo in cui la temperie ordinaria della vita quotidiana era l’angoscia – l’angoscia del coevo uomo-medio, di massima un contadino con un’aspettativa media di 30 anni di vita dura, rinchiuso nel borgo fortificato del feudatario (al cui servizio era indotto con la violenza), circondato da boschi invalicabili brulicanti di lupi e di furfanti, da cui, essendosi nel frattempo perduta la conoscenza della rotazione annuale dei campi, quasi ogni anno si disboscavano faticosamente rettangoli di territorio da mettere a cultura, appezzamenti che dopo un paio d’anni erano già sterili (e ci volevano 9 contadini per dar da mangiare a 10 persone…); in questo tempo d’angoscia dunque la casa “eterna” di Dio veniva a comporsi come una stazione intermedia tra la condizione terrena e la promessa paradisiaca del riscatto: un diaframma, una scheggia d’universale che, come insegnava Aristotele, essendo infinito, era infinito e assoluto anche in quel suo menomo granello. In altri termini, se i pensatori del tempo si spremevano a gara le meningi onde dar luogo a compendi d’onniscienza (ove era notevole la convergenza tra pensiero, religione e scienza), le celebri Summae Teologiche, ecco che la cattedrale romanica veniva a porsi come una Summa Teologica architettonica, i cui arredi scolpiti o ad affresco erano i capitoli del grande racconto cosmico. Quando questa struttura valoriale fu consolidata, le abbazie spuntarono in tutta Europa come una messe particolarmente fertile. Esse incentravano in sé ogni categoria del sapere, dalla formazione alla ricerca, dalla scienza alla teologia, alla botanica, la grammatica, la musica. Le Arti Liberali vennero in auge, sorgevano le università. Nei primi secoli del nuovo millennio si produsse una tale accelerazione tecnologica, quale non si vide più al mondo fino agli albori della rivoluzione industriale, alla fine del ‘700. Questa “rivoluzione”, pienamente riconducibile allo spirito dell’uomo romanico, concesse i suoi ultimi contributi all’arte delle cattedrali, prima di cedere il passo all’ambizioso progetto di montare in cielo, ossia all’arte verticale, al Gotico.
Tecnicamente, questa lunga resurrezione trova riscontro nelle grandi cattedrali benedettine dell’undicesimo e dodicesimo secolo, di cui, quella di Cluny- l’allora più grande chiesa d’Occidente- rimase lungamente la capostipite. L’ora et labora dei Benedettini era diventato un po’ il “blues” del Medioevo, e aveva finito per informare di sé, divenendone l’ideale, l’intero consesso intellettuale, che risaliva la china di secoli d’oblio illetterato e di accidia quasi animale. Fu in questa atmosfera di zelo quasi mistico che la tecnologia compì il passo decisivo per la nascita (o la ri-nascita) dell’Occidente, dell’Europa, o di ciò che tali nomi infondono nelle coscienze.
Pertanto, la “volontà” romanica primitiva è quella di dare una casa stabile e duratura al Dio. A tal uopo essa dev’essere edificata in pietra- in un panorama urbano ancora dominato dal legno. Deve, al pari dei colossi romani dei Fori, travalicare i tempi, candidarsi all’eternità. Già, ma i Romani non gli han lasciato che due soli strumenti atti a edificare: il compasso e l’arco. E il problema immediato che si manifesta ai primi Mastri carpentieri, è la copertura, cioè il ”coperchio”, della volta. È noto che in tempi remoti il problema era così irresolubile che, onde coprire il celebre Mausoleo di Teodorico, a Ravenna, si ricorse ad un unico blocco di granito, fatto giungere via mare fin nella sua sede e colà scolpito e poggiato semplicemente sopra a mo’ di coperchio (proveniva dalla Croazia, ed è rimasto avvolto nel mistero il metodo usato per collocarlo- forse un sistema di allagamenti mirati). Il problema era quello delle spinte, ossia dei carichi di peso che gravavano sulle strutture di base.
Ora, il concetto primario di “casa” si basa sulla figura sintetica di quattro segni: due segmenti verticali sui lati e due obliqui che li congiungono in uno spigolo: la forma “a capanna”. Anche un bambino la disegnerà così. Tale forma postula la necessità di un tetto, solo così sarà davvero “casa”. E le linee spioventi, come dice la parola, servono a far scorrere sui lati la pioggia. Nelle chiese paleocristiane e proto-romaniche i due muri laterali sono congiunti dalle capriate, enormi assi di legno poste trasversalmente e che, composte a triangolo con altre assi analoghe al di sopra, formano lo scheletro del tetto. Queste assi danno inoltre stabilità alla struttura, “legando” assieme le strutture murarie. Se invece di queste assi, avessimo una copertura in pietra, questa non troverebbe sostegno al centro e crollerebbe. Se invece poggiassimo semplicemente un tetto di pietra a spioventi, i suoi due lati terrebbero al centro, poggiando l’uno contro l’altro, ma la spinta cadrebbe sui muri laterali, “allargandoli” e facendoli cadere. La soluzione stava quindi nell’adozione di un sistema di contro-spinte e di archi. Gli archi avrebbero scaricato i gravi delle spinte su determinate giunture della struttura muraria, e qui si sarebbe adottato appunto un sistema di contro-spinta, il contrafforte. Questi appare originariamente come un rinforzo a base quadrata posto a intervalli regolari lungo l’asse perimetrale della costruzione. Quindi, l’arco scarica sul contrafforte la spinta della propria partitura muraria, e il contrafforte lo riceve in alto e lo scarica a terra. Il tutto in un sistema di mura possenti che, essendo auto-reggenti, non sopportano che aperture molto limitate. Di qui l’inadeguatezza della penetrazione luminosa all’interno e la nota e per noi “mistica” oscurità che avvolge le antiche chiese romaniche.
Le “mura possenti” potevano anche assolvere ad un altro scopo: la difesa. Potevano servire a difendersi da chi dall’esterno coltivasse cattive intenzioni, il che non faceva proprio eccezione, essendo concepita l’intera unità di chiesa e abbazia come una specie di ideale mini archetipo dell’aldilà, in un “aldiquà”, invece, ingiusto e dominato dall’angoscia e dalla penuria. Varcata la soglia della cattedrale, si penetrava nell’”altro mondo”, ossia nel Bene che avrebbe accolto coloro che fossero vissuti secondo virtù. La facciata della chiesa era quindi una soglia, un limine che discriminava fra il Bene e il Male, fra Cielo e Terra, fra Paradiso e Inferno. Ecco il senso della decorazione insistita, gremita, traboccante di simboli e figure, tutti allusivi ad un monito morale del credente. Il quale, se vuole oltrepassare la soglia che lo conduce dalla sua miseria alla “vita paradisiaca”, deve redimersi, fare penitenza. E la via che gli si svela all’interno è come la sintesi del pellegrinaggio che egli, al fine appunto di riscattarsi, deve intraprendere. Nella cattedrale romanica compiuta, il “viaggio” del pellegrino inizia dall’ingresso del portale posto alla sua destra: i tre accessi ordinari posti in facciata, introducono alle navate tripartite, suddivise da pilastri o colonne che delimitano dei riquadri, le campate, a volte assai differenziate e originali, altre in continuità con l’andito della navata. Per edificarle i carpentieri navali ricostruiscono il medesimo scheletro di impalcature atto alla realizzazione di uno scafo: di lì il nome. Appena entrato, percepisce la gigantesca forma di croce su cui poggia i piedi: è la pianta a croce latina, alla cui intersezione del braccio lungo con quello corto (il transetto), si trova il coro, il cuore della costruzione, cosi denominato per via delle funzioni liturgiche cantate che ivi trovavano luogo. Questo, qualche volta è sopraelevato di qualche gradino. L’altare vi troneggia di massima davanti.
Il pio viandante contemporaneo ammira adesso esterrefatto le sgargianti decorazioni policrome che, non ostante il buio, spiccano sui muri e sulle volte del tempio. Sono piuttosto astratte, “espressioniste” se vogliamo. E non solo per ignoranza delle regole prospettiche, ma perché siamo “in cielo” e lassù non vige il “realismo” disperato dell’uomo medioevale, ma una specie di “surrealismo” simbolico, paradisiaco, trascendente, la cui dominante cromatica è l’oro e dove la rappresentazione realistica, la Mimesis, è superflua o addirittura controproducente, essendo la realtà associata alla caduta del soggetto, e non alla sua apoteosi. La vita umana è caduta nel degrado, nella fame, nell’angoscia: non c’è bisogno di alcun “realismo” che celebri questa realtà. Il valore della vita è altrove dalla vita, e non deve assomigliargli. E vedremo come queste premesse, col migliorare delle condizioni di vita, finiranno via via per capovolgersi. Per ora si annunciano nei colori sgargianti di affreschi e mosaici, nei contorni fortemente rilevati del disegno, affini all’arte vetraria, ma necessari per renderli leggibili nel buio raccoglimento dell’area sacra.
Percorso il corridoio della navata laterale destra, il viandante penetra ora nell’altro corridoio a emiciclo che curva intorno al coro, il deambulatorio. E passa in rassegna una serie di cappellette poste a raggiera tutt’intorno, le cappelle radiali. Ognuna contiene una reliquia ed è suo dovere fare atto di devozione in tutte. Qualche volta, posto in asse centrale con la navata maggiore, incontra un abside, con altare e reliquia d’obbligo, altrimenti è l’intero deambulatorio a fungere da abside. Percorrendo a ritroso il cammino precedente, ma nella navata laterale opposta, osserverà ancora le figure scolpite a capitello sul culmine dei pilastri (a volte semplicemente quadrati, sennò a colonne addossate, o magari riassunti in un’unica colossale colonna), al di sopra dei quali, non se n’era accorto prima, corrono corridoi porticati sulle due navate laterali: sono i Matronei, le gallerie riservate alle donne, separate dagli uomini, secondo l’uso del tempo. I capitelli scolpiti rappresentano figure bibliche di mostri e di martiri, poste a memento del peccatore con raffinato espressionismo. Le medesime figure le ritroverà sui portali uscendo di nuovo all’aperto, in strisce verticali intervallate da colonnine, fregi e nicchie varie, che, in alto, girano intorno all’architrave del portale.
Ecco, percorso l’intero itinerario, il viaggiatore avrà simbolicamente compiuto il suo pellegrinaggio a Santiago de Compostela, guadagnandosi un pezzo di redenzione. È entrato e uscito dal “Paradiso” e si sente rinfrancato. Qualche volta è potuto persino penetrare nel bel chiostro, un giardinetto quadrato, recinto da corridoi porticati a colonnine, dai quali di solito si accede alla chiesa, ove i frati meditano e pregano. E dove si affacciano la sala consiliare e il refettorio, spesso coperte da volte costolonate, come quelle della chiesa e del porticato esterno. Colà ricevono acqua e cibo, magari, o altrimenti son loro stessi a recarli. È un piccolo viaggio santo che serve a tener desto nel fedele l’auspicio della vita migliore che l’attende in quell’altrove di cui questo luogo non è che il modellino parziale e “finito”, per così dire. Ne serberà il ricordo nelle sue preghiere e nei suoi sogni di una vita migliore.
- Blog di Hjeronimus
- 1003 letture

 Sostieni anche tu il nostro sito
Sostieni anche tu il nostro sito
 le nostre pubblicazioni
le nostre pubblicazioni