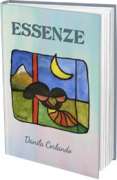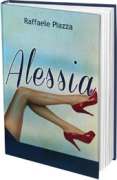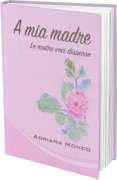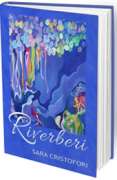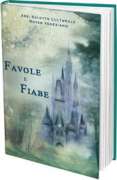I miei nonni possedevano una vecchia casa in pietra e sasso, in un paesetto della bassa friulana. Adesso è provincia di Pordenone, ma, negli anni sessanta, era Udine.
Bepi l'aveva acquistata nel lontano 1930 per mandarci i cinque figli in vacanza durante l'estate, assieme alla moglie e alla donna di servizio. Fotografie dell'epoca, quelle con i bordi frastagliati, rappresentano mia madre e i suoi fratelli con le facce accaldate, seduti nell'orto, i capelli tagliati cortissimi e a piedi nudi.
Con il passare del tempo, in quella casa, ci andammo noi, i nipoti.
Era una casona a quattro piani, con i caratteristici poggioli esterni in legno, lunghi tutta la facciata, detti " piòl".
Per noi bambini di città, e di citta di mare, andare in campagna era davvero cambiare mondo! Non sapevamo nulla di animali domestici, salvo gatti cani e colombi, e solo in campagna potevamo vedere le vacche, di sera, andare ad abbeverarsi alla larga fontana della piazza, menando la coda come una frusta lasca e lasciando a terra enormi, morbide " boàsse".
Poi si vedevano i muli, i cavalli, i maiali ( qualcuno fuggì dal porcile correndo di gran carriera lungo la strada verso le colline) , i conigli... Per un mese, insomma, eravamo bambini campagnoli ed era singolare come parlassimo nel nostro dialetto veneto con gli amichetti del posto, che parlavano il loro. Ma ci intendavamo benissimo. Loro ci dicevamo " Ciò venessiàn ! ".
Partivamo da Venezia con un treno diretto a Udine, che ci sbarcava armi e bagagli a Sacile. Da lì si prendeva una specie di tradotta con la locomotiva a vapore. Pare impossibile, ma negli anni sessanta, in tratte minori, la vecchia locomotiva sbuffante con il macchinista nero come il carbone, esisteva ancora.
Una volta lessi in un racconto di Pasolini, che da ragazzo, quand'egli andava in ferie da Bologna a Casarsa, s'accorgeva di essere entrato in Friuli dall'odore polveroso dei platani, i cui rami sporgevano lungo la massicciata della ferrovia. Ed è verissimo! Non appena si apriva la campagna coltivata, in prossimità delle colline, si sentiva subito che cambiava l'aria rispetto alla pianura e quell'odore lì io lo ricordo ancora e lo sento tutt'ora, quando ritorno al paese. L'odore delle foglie verdi dei platani.
Come si arrivava alla casa, in una stradicciola che menava alle " rive" ( ossia le colline) , la prima cosa era buttare via scarpe e calze ed infilare gli zoccoletti di legno, con la mascherina di pelle. Mi facevo un intero mese con gli zoccoli. Alla fine avevo le piante dei piedi quasi callose.
Se non erano gli zoccoli, mettevamo gli " scarpìt" , ossia le scarpette di stoffa, fatte dalle donne del paese, con una serie di suole sottili, cucite con lo spago una sull'altra, e l'ultima rivestita di copertone di bicicletta, cosa che rendeva gli scarpìt quasi indistruttibili, salvo uscire fuori con l'alluce, a fine stagione. Questo a causa del fatto che, correndo in bici, si frenava con i piedi.
Mi abituavo talmente agli scarpìt che, quando tornavo a Venezia, non volevo saperne di rimettere le solite scarpe.
Altro aspetto magico di quella casa, era rappresentato dal fatto che non in tutte le camere da letto c'era la corrente elettrica, per cui la sera, all'ora di dormire, si saliva per le scale con la candela accesa e un pacchetto di fiammiferi. Me la ricordo ancora l'ombra mia che s'allungava seguendo la tromba delle scale, e mio cugino dietro, che domandava se in casa ci fossero i fantasmi.
Mentre salivamo le rampe, era tutto uno scricchiolìo perché scala e pavimenti erano in legno grezzo, semplici assi piallate. Avevo imparato a mie spese a non camminare a piedi nudi, perché spesso rimediavo qualche scheggia di legno, e dopo ci pensava la donna di servizio, a togliermela con la punta incandescente dell'ago da cucito.
Tutto quello che si mangiava in campagna era buono. A me pareva più buono che a casa. Soprattutto il formaggio cotto, fuso, che la nonna stendeva sopra una fetta di polenta gialla. La polenta friulana è tosta, bella macinata grossa.
Il mese di luglio era un mese di libertà assoluta. Alle nove eravamo in strada per giocare con i bambini del paese... a parte le corse su biciclettine sgangherate ( io non ho mai saputo a chi fosse appartenuta quella che usavo io...) ci piaceva fare delle esplorazioni in mezzo alla boscaglia che si apriva subito dopo la fine del paese, con noccioli, faggi, castagni e arbusti con grosse bacche carnose ; bacche che tra noi dicevamo essere velenosissime.
Una prima meta era una fontana d'acqua sorgiva, trasparente e gelida, dove tra alghe lunghissime color verde-blu, nuotavano pesci che nessuno di noi riuscì mai a catturare. Qualcuno diceva che erano piccole carpe, altri pesci-gatto. Fatto sta che io non ne ho mai preso uno, anche se immergevo le braccia fino al congelamento, cercando di afferrarne. Attorno a questa fontana, che aveva un nome inquietante dato dalla gente del posto, ossia El bùs delle Anguàne ( ossia il Buco delle Streghe), si alzava una frescura piacevolissima, anche nel pomeriggio più torrido, per la qual cosa ci portavamo da casa vecchie pignatte d'alluminio, le riempivamo di acqua e mettevamo i piedi a mollo.
In altre occasioni, ma solo se le giornate erano ventilate, noi bambini si andava, accompagnati da qualche adulto, in gita alla sommità della collina, dove si ergeva una chiesa bianca con il suo campanile. Chiesetta che vedevo bene anche dal treno, durante il mio viaggio di andata e che sembrava essere il primo cenno di saluto familiare.
Ricordo che eravamo una decina di bambini, fino ai dieci anni di età. Arrampicarsi per la strada sterrata con zoccoli o sandaletti non era facile, ma reggevamo lo sforzo. Spesso cantavamo a squarciagola. Gli adulti, ossia la donna di servizio della nonna e una mia zia, portavano in due ceste la nostra merenda che spesso, oltre ad essere pane con la marmellata, poteva anche trattarsi di un budino di cioccolata freddo, tremolante, chiuso nel suo stampo.
Arrivati all'ombra del campanile, si stendevano due vecchie coperte che ci punzecchiavano le gambe, e sedevamo tutti in attesa della merenda.
I maschi, ancora con la bocca piena, sparivano nella macchia a caccia di farfalle o cavallette ; io e i miei cugini andavamo a graffiarci a sangue , dentro ai rovi, per trovare ciclamini, fiori che da quelle parti spuntano copiosi. Anzi: ognuno di noi aveva la sua zona segreta in cui rovistava per raccogliere i ciclamini più grossi, assieme alla patata.
Un posto dove avevamo il divieto assoluto di metter piede, era la discarica del paese, in prossimità della ferrovia, chiamato " Ruòja". " No andè intè la ruòja" , ci ammoniva ogni mattina mia nonna, la quale riprendeva a parlare il suo dialetto nativo. E invece ci andavamo di nascosto, eccome se ci andavamo...
Bisognava però pedalare di buzzo buono, perché il posto era molto distante e isolato. Ricordo che attraversavamo campi di granturco e tratti anche con canali d'irrigazione, per raggiungere questo paradiso di strane cose. Nella ruòja non c'erano rifiuti velenosi, ma erano stati buttati vecchi oggetti , stufe, elettrodomestici, mobili rotti, materassi. Io restavo ai margini a sorvegliare le biciclette, ma i miei compagni si mettevano a rovistare alla ricerca di qualche tesoro. In verità l'unico vero pericolo era che ci potevamo ferire, perché il posto era pieno di chiodi e cocci. Non so come facessimo a resistere al caldo africano del primo pomeriggio. Io sedevo sotto un grande pioppo che segnava il crocevia, sentivo le cicale frinire all'impazzata e seguivo i voli in picchiata dei rondoni. Ogni tanto chiamavo per nome i compagni che erano spariti alla mia vista.
Un giorno, al ritorno, ci soprese un temporale furibondo, come solo in Friuli sanno esplodere, in piena estate, a causa di un gioco di correnti fredde che vengono da nord. In cinque facemmo appena in tempo a raggiungere il sottopasso della ferrovia e fummo colti da una grandinata di chicchi di ghiaccio, grossi come nocelle. Quando quel diluvio si calmò , la temperatura era scesa di colpo di parecchi gradi e la strada sterrata era una palude. Rincasammo con le bici a mano e del tutto scalzi, tanto era il fango incontrato per via.
Alla sera, dopo cena ( mangiavamo in fretta e furia per goderci gli ultimi giochi fino oltre l'imbrunire) noi bambini uscivamo in giardino, poiché nell'ombra scura era tutto un fiorire di lucciole e noi le cercavamo con il bicchiere, per catturarle. Mio cugino pretendeva che le lucciole rimanessero accese anche in casa e non si spiegava perché, una volta dentro, non facessero luce.
La nonna e le altre donne, invece, sedevano alla porta di ingresso, secondo la tradizione di quei paesi, portando fuori le seggiole, e chiacchieravano sottovoce di fatti accaduti, di figli, di parenti emigrati o del prete. Ogni tanto passava qualche vicino, si interrompevano, salutavano e riprendevano a bisbigliare.
Quando dalle colline scendeva un fresco rèfolo, unico ristoro alle giornate afose, e la luna gialla come una frittata, si stagliava alta sulla piazza, allora era giunta l'ora di andare a dormire. Mio cugino, molto più piccolo di me, già ronfava da un pezzo, in braccio alla donna di servizio.
- Blog di maria teresa morry
- 568 letture

 Sostieni anche tu il nostro sito
Sostieni anche tu il nostro sito
 le nostre pubblicazioni
le nostre pubblicazioni