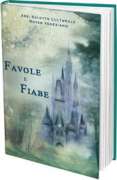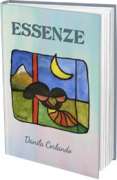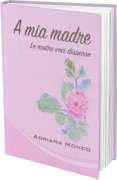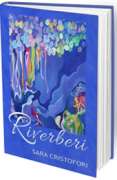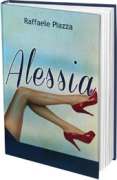La storia che voglio raccontarvi è una storia semplice. Un semplice altalenarsi di colori pastello tra il semilucido e l’opaco. Che tanto assomiglia all’alone della vecchiaia che avanza e costringe a volte a incollare e scollare ciò che v’è da scollare per rincollarlo. E questa vicenda vorrei proprio riportarla, come si faceva una volta, quando si raccontavano gli accaduti intorno ad un fuoco acceso, ed anche questa, iniziarla come si faceva allora… C’era una volta intorno all’inizio del secolo scorso, quando era più facile andare a piedi che trovare un passaggio da un carro trainato da buoi, un uomo lungo la strada.
Magro come un chiodo, con una giacca due misure più grandi e pantaloni di fustagno colore dei tronchi degli alberi che oltrepassava a due per volta ogni venti secondi. Percorreva un percorso di migliaia di volte percorso, su una strada da sempre uguale; identicamente uguale a quella stessa della sua infanzia. Se avevi la fortuna di poterlo osservare attentamente anche sotto la barba bianca, due rughe dalla metà del naso scendevano sino al mento come due parentesi intorno alla bocca; ma questo, in fondo in fondo, ha poca importanza. Torniamo invece al suo camminare. Quel percorso tante volte fatto, glielo leggevi nella noia che in fondo all'iride potevi intravvedere, così tanto per dire, anche in quell’unico pensiero che portava dentro al cuore, grande come tutta la sua vita. Poi, in men che non si dica, vi rintracciavi pure un acquerello appiccicato alla parete dei suoi ricordi: una donna lontana che difficilmente sarebbe tornata, con due bambini che la seguivano stuzzicandosi l’un l’altro. Ma lui sempre ci sperava e ci sorrideva. Capace come nessuno, di sorridere all’impossibile.
E mentre pensava alle speranze impossibili, camminava. Leggermente curvo con il passo cadenzato e lento, incurante del nulla che gli accadeva intorno e delle pochissime auto che passavano borbottando sul centro della strada alzando polvere e suonando sempre ed immancabilmente, quella trombetta tipo:“poti poti.” Camminava lento dicevamo, sul bordo della via, su terra di bosco che la strada a quel bosco aveva rubato, una striscia colore ocra che come un serpente terminava appena oltre il paese sovrastante.
Un fagotto appeso ai bastoni degli attrezzi da campagna tenuti insieme da due lacci, uno in basso ed uno in alto. Dai nodi ben stretti. Il tutto appoggiato sulla spalla ed all’avanbraccio a bilanciarne il peso. Un cappello a falda larga nero come il carbone con un nastro che pendeva da un lato come un vezzo. Un leggero vento gli faceva volare quel nastrino come una brandello di stendardo strappato in mille battaglie. Mentre intanto spazzava la polvere che le poche auto alzavano al passaggio. Lui ogni volta ne tossiva con noncuranza.
Il paese come ho già detto, era un poco più oltre. L’ultimo tratto sarebbe stato il più faticoso per un uomo della sua età. La sua casa era l’ultima alla fine delle case, oltre la piccola piazza del municipio. Si chiamava Anton quel paese. Ed anche Anton era ormai stanco di camminare. Si perché vi sembrerà incredibile ma ambedue avevano lo stesso nome. Sia la nostra comparsa che il paese avevano l’identico nome e quell’ultimo spesso si divertiva a creare confusione con l’interlocutore di turno sul fatto di chiamarsi Anton di Anton e davanti ad un buon bicchiere di vino, giù risate a morir dal ridere.
Questa volta invece del vino, l'occasione di bere un sorso ad un filo d’acqua che scendeva da chissà dove cadendo lì sulla strada ed alla mattina mai avrebbe pensato di dedicarsi ad altri tipi di bevute, che bere vino era solo un momento della sera durante la cena e a volte a finir il bicchiere con un cucchiaio di zucchero ben girato toccandoci dentro l’avanzo del pane della cena.
Lui era nato in quel paese e la strada era la stessa di tutta la vita. E come ogni mattina si fermava al bar sulla strada. Una specie di emporio dove si poteva comprare quasi di tutto. In realtà era l'osteria del paese, ancor prima di arrivare al paese.
Spinse la porta in legno che lo separava dall’interno. E quando entrò sulla scena calò il sipario e piegata la schiena sugl’anni infranti, si sedette sulla solita sedia di tutte le mattine. Ma quella volta era chiaro già da come si era seduto, che non avrebbe partecipato in silenzio al silenzio di ogni mattina ma avrebbe parlato. Ed infatti fu così che da lì a poco, un decamerone di vita fu srotolato in pubblico, e lì si raccontò della sua storia accorsa al mese tredici del giorno seguente di quell’ultimo giorno sfuggito.
Il suo parlare era lento, quasi incerto, dietro alla barba del color di quel bianco del pane appena sfornato, ma il tono era austero, chiaro e deciso. Posso anche dire che quel giorno io c’ero, ed è per questo che ne parlo con tanta dimestichezza. Sarà stato quello stesso impossibile di colori e di vita vissuti o disertati, passati come è facile pensare come un volo d’appena sfiorato; ma egli lo tagliò come si taglia il pane sul tavolo della mensa la Domenica del dì di festa. Ed io lì ad ascoltare come si ascolta chi deve parlare. E con ossequio il silenzio gli lasci inondare.
Eppure intuivo le intensità sfuggite e le tendenze di livido da vecchi film. E bigio il cielo, del grigio pensiero sotto la pioggia che bagna l’asfalto che l’auto francese tritava lo stesso asfalto e i miei anni migliori… Ricordi? E ora mi si perdoni se mi incespico a parlar di me e di parlarne con voi che leggete... La ricordo perfettamente come se fosse adesso. Celeste opaca, sopra le pozze del bianco di neve e presagio di lacrime rosse al pensiero che andava. Verde fu invece l’ottavo giorno mai sorto al muschio del bosco. I funghi spuntati che lasciarono un leggero strato di umido odore vacuo di bosco, di castagno, di albero tosto e nervoso e al sole arancio della spiaggia della mia infanzia. Il blu fu all’ora venticinque, e il giallo di chi libero vive. Fu storia passata e poi lasciata lì come fango riseccatosi sul sentiero.
Ma torniamo alla nostra storia. Tutti conoscevano Anton. Aveva costruito una casa con le sue mani cinquant’anni prima quando ne aveva venti e si era sposato con una donna che dopo aver messo al mondo due figli, alla nascita del terzo morì di parto e anche il piccolo morì. Egli si trovò solo coi due marmocchi rimasti. Ma i guai non erano terminati anche i due bambini morirono, prima l’uno poi l’altro. La tubercolosi accompagnò il primo e l’altro finì sotto un carro mentre attraversava la strada. Erano anni brutti ma brutti veramente.
Dopo alcuni mesi dalla morte dell’ultimo figlio, Anton vendette metà della casa. La divise in maniera verticale dall’alto verso il basso e prese per se la parte verso il monte e mise in vendita la parte verso valle. Nonostante la rude scorza contadina che obbligava a non pensare troppo ed a non perder troppo tempo dietro gli orpelli della vita ed a pensar solo al lavoro, forse troppo solo si ritrovava alla sera e troppo solo era già al mattino, che quando aprendo la finestra della stanza non poteva non vedere la strada che sotto i due tornanti aveva portato via la vita di uno dei suoi due figli neppure il tempo di sentirsi esaurito che fece la scelta. Fu una scelta difficile. La notte ci pensava e al mattino non apriva la finestra perché sapeva che gli sarebbe venuto da piangere e non si poteva cominciare una giornata piangendo… diceva. Alla fine si convinse che sarebbe stato bene disfarsi di quel supplizio e fece l’affare con un villeggiante che vi andava solo d’estate per una ventina di giorni.
Conosci la strada per Santiago? Dimmi, conosci la strada per Santiago? Dimmi, la conosci o no? Dai, dimmi se la conosci? Mi chiese ripetutamente un giorno molti anni dopo, quando ormai pareva, agli occhi di tutti, quasi rimbambito e parlava ripetendo in continuazione le stesse domande. Risposi di si e che sapevo di quella strada e aggiunsi: “Marrone come la cartina tornasole e che una volta camminai col bastone al centro del cerchio. Camminai col bastone e la fiamma guizzava e brillava, e sfavillava e rosseggiava… balda e audace come in una poesia. Ma il tredicesimo mese il palco fu viola e tutti urlarono… e io pure… E fu così che tornai dal cammino di Santiago. Tornai e da lì ricominciai a pregare… e non solo Dio.” A quella risposta rimase in silenzio attonito. Da quel momento, per anni e anni, se m’incontrava per strada e mi fermava per parlare del più o del meno, ma mai ritornò su quell’argomento.
Ricordo però che fui proprio io a nominargli di quell’autista che fuggì con mezzo e tutto e dell’accendino rosa che pendeva sotto l’armadio. Un’altra volta gli raccontai del bus che occhieggiò la biondina mezza svestita e alla luce verdognola quasi improvvisamente, scoppiava la penombra e il buco via via si fece sempre più grave e quasi s’ammalò. Gli raccontai anche del proletario che piegò il drappo strappato e che ebbi appena il tempo di vederlo garrire, un attimo soltanto, da un ultimo vento bizzoso e da una mano non incline al ripiego. Gli dissi pure che quella volta, sorrisi felice di averlo veduto ancora, anche se solo per quell’istante, da poterlo almeno raccontare… e la cosa più bella fu poterlo raccontare proprio a lui. Ricordo, mi annuiva e fu lì che capii che era l’unico che capisse quel che intendessi dire e quindi azzardai: “E dove tutto non abbia perso il senso” aggiunsi: “Ancora mi siedo volentieri e guardo, laddove il bianco, sia di bianco vestito, e il nero sia nero, di nero pregato. Non rinnego il mio tratto, lo ammetto, ed al mio petto poso spesso ancora una mano e ascolto battervi dentro il cuore.”
A quest’ultima battuta lui fece l'atto di applaudire - e poi lo fece sul serio - ripetendo una specie di bravo bravo, che mi sembra ancora di rivederlo applaudire con gli occhi lucidi dalla commozione…
Poi nella sua vita si sposò ancora una volta ed ebbe un figlio che chiamò come io mi faccio chiamare ed ebbi anche la fortuna di diventargli amico e fu proprio egli che mi parlò di lui.
Ma questa è un'altra inimmaginabile pagina per un altra sera intorno al fuoco di questo camino che è il nostro scrivere e il nostro leggere quaggiù tra noi...
 Tre stelle brillano nel cielo in questa notte calda. Esco dal bagno avvolta nell’accappatoio e scivolo nella mia camera, a piedi scalzi. Decido di indossare per la prima volta dopo tanto tempo la mia camicia da notte di lino viola e mi butto sul letto. La casa è buia, l’unica luce accesa è quella della mia camera da letto, fioca, devo cambiare lampadina. La porta-finestra è socchiusa e uno spiffero d’aria solleva le mie tende color pastello, facendo disegnare loro ampi cerchi concentrici. Finalmente è estate. Pensieri senza forma rimbalzano qua e là nella mia testa mentre cerco istintivamente un foglio straccio e una matita che si possa definire tale. E’ sempre così: quando sento il bisogno di scrivere mi prudono le dita e devo chiudere gli occhi forte per non lasciar scappare il pensiero che ho in testa. Recuperato un moncherino e un block notes mi butto avidamente sulla carta: che bello scrivere. Osservo felice il mio pensiero che finalmente ha preso forma, la forma di tante lettere e parole che danzano nella mia stanza e che mi sorridono. Scrivo, scrivo e non mi fermo, è difficile trovare un modo per concludere i pensieri di quella giornata. Perché se riesco a trovare una fine per il mio racconto, non posso dire lo stesso dei miei pensieri, che si evolvono e crescono, durante tutta la notte. Scrivo di me, di quello che ho in testa, di quello che penso e di come vorrei cambiare il mondo. Scrivo delle mie emozioni, dei miei sentimenti, delle cose che mi succedono. Scrivo delle mie manie, della Terra che si trasforma, di come vedo le cose, di come considero le persone. Scrivo di tutto.
Tre stelle brillano nel cielo in questa notte calda. Esco dal bagno avvolta nell’accappatoio e scivolo nella mia camera, a piedi scalzi. Decido di indossare per la prima volta dopo tanto tempo la mia camicia da notte di lino viola e mi butto sul letto. La casa è buia, l’unica luce accesa è quella della mia camera da letto, fioca, devo cambiare lampadina. La porta-finestra è socchiusa e uno spiffero d’aria solleva le mie tende color pastello, facendo disegnare loro ampi cerchi concentrici. Finalmente è estate. Pensieri senza forma rimbalzano qua e là nella mia testa mentre cerco istintivamente un foglio straccio e una matita che si possa definire tale. E’ sempre così: quando sento il bisogno di scrivere mi prudono le dita e devo chiudere gli occhi forte per non lasciar scappare il pensiero che ho in testa. Recuperato un moncherino e un block notes mi butto avidamente sulla carta: che bello scrivere. Osservo felice il mio pensiero che finalmente ha preso forma, la forma di tante lettere e parole che danzano nella mia stanza e che mi sorridono. Scrivo, scrivo e non mi fermo, è difficile trovare un modo per concludere i pensieri di quella giornata. Perché se riesco a trovare una fine per il mio racconto, non posso dire lo stesso dei miei pensieri, che si evolvono e crescono, durante tutta la notte. Scrivo di me, di quello che ho in testa, di quello che penso e di come vorrei cambiare il mondo. Scrivo delle mie emozioni, dei miei sentimenti, delle cose che mi succedono. Scrivo delle mie manie, della Terra che si trasforma, di come vedo le cose, di come considero le persone. Scrivo di tutto.


 Sostieni anche tu il nostro sito
Sostieni anche tu il nostro sito
 le nostre pubblicazioni
le nostre pubblicazioni